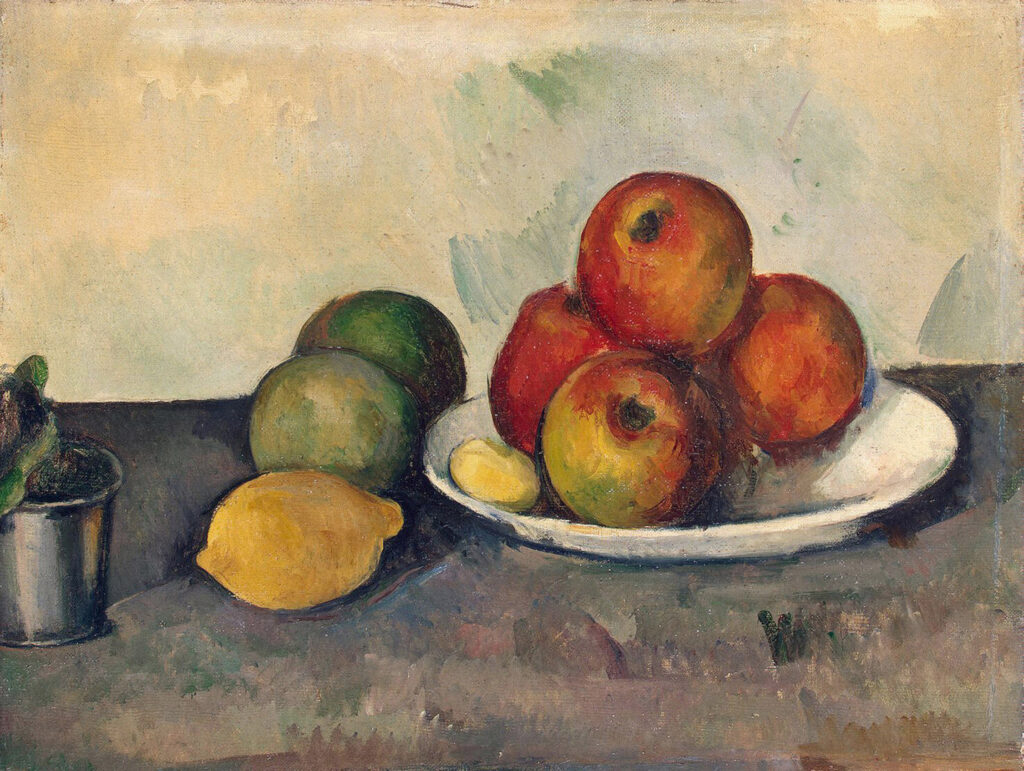“Che bello!” è una storia semplice semplice, scritta da Antonella Capetti e illustrata da Melissa Castrillon, che dimostra come si possa fare filosofia con i bambini. La tesi è vecchia quasi quanto la filosofia stessa. La sosteneva già Epicuro circa duemilatrecento anni fa nella lettera a Meneceo: non si è mai troppo giovani, né troppo vecchi per filosofare, perché non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per essere felici.
Una bambina raccoglie un bruco, lo guarda, ed esclama: “come sei bello!”. Il punto esclamativo diventa subito un punto di domanda gettato come un amo nella mente del bruchetto: “cosa vuol dire bello?” Sebbene rivisitata in stile linguistic turn, la domanda ha ancora tutto il sapore del socratico ti estì. E socratico è il modo di procedere dello strisciante protagonista che interroga uno dopo l’altro tutti gli animali della foresta senza trovare mai una risposta che resista alla confutazione dell’amica cornacchia, pennuta epigona del demone socratico, incarnazione alata del momento negativo della dialettica, vero motore del procedere dello spirito.
“Questo è bello!” risponde l’orso col muso nel miele. Ma no, gracchia la cornacchia, quello è buono! L’amico orso ha fatto due errori in un sol colpo. Il primo è quello di aver portato un esempio concreto ove gli si chiedeva una definizione, il secondo di aver scambiato il bello con il “piacevole”. Ogni volta che si cerca una definizione occorre saper tracciare una linea di demarcazione, indicare un confine tra ciò che una cosa è e ciò che essa non è. Il bello non è il piacevole. Certo possono apparire simili, l’uno e l’altro piacciono, ma piacciono in modo diverso. Il miele, osserva la cornacchia, piace all’orso, la foglia al bruco, il bruco alla cornacchia.
Insomma, converrebbe Kant, il miele è oggetto di un desiderio tutt’altro che disinteressato. L’orso non si limita a contemplarlo e non desidera condividerlo, ma vuole goderne in modo esclusivo, lo vuole per sé. Esso soddisfa una sua particolare inclinazione, un gusto che riposa nella dimensione empirica della soggettività e che non pretende di elevarsi all’universale. Per dirla in modo semplice e con una battuta, l’orso non si offenderà certo se il bruco preferirà la propria foglia al suo miele.
Conoscere, si sa, vuol dire trovare le differenze. La dialettica procede a definire i concetti più “per forza di levare” che di porre. Per via di negazione abbiamo stretto il campo intorno al nostro oggetto di indagine, togliamo via il piacevole e vediamo cosa ci rimane.
Procedendo in questo modo il piccolo protagonista confuta uno dopo l’altro gli scoiattoli, il topo, il cervo, la talpa… e la stessa cornacchia in una negazione della negazione che sembra votare l’indagine allo scacco. Ma proprio quando scende la notte e il buio avvolge ogni cosa, la verità della bellezza si manifesta nello splendore di uno spettacolo che rimane innominato. “Che bello!” esclamano in coro gli animali col muso all’insù.
Il percorso socratico ha condotto sulla soglia di una risposta kantiana: il bello è ciò che piace in modo universale, disinteressato e senza concetto.
Che sia un bruco, poi, a porsi sulle tracce della bellezza sembra tutt’altro che casuale. Ci piace pensare che il protagonista, dopo aver imparato a riconoscerla fuori, possa trovare in sé la bellezza presagita dalla bambina all’inizio della storia e che alla ricerca intellettuale corrisponda una effettiva trasformazione del soggetto che la compie.